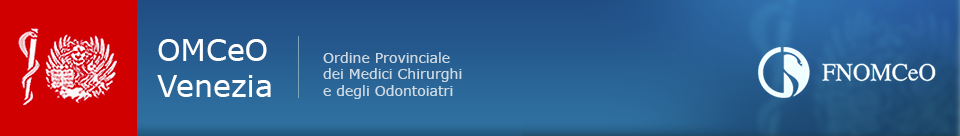- Home
- News
- Odontoiatri
Pazienti stranieri, una gestione difficile. Ma si può fare
Data di inserimento: Giovedì, 14/02/19 - Segreteria OMCeO Ve

Hanno colto al volo l’occasione di “svuotare il sacco”. Senza reticenze – «Se non ci diciamo la verità, tutto questo non ha senso», li ha incalzati il segretario dell’Ordine Luca Barbacane, uno degli organizzatori del corso – non si sono fatti pregare: hanno preso in mano il microfono e raccontato ai colleghi e agli esperti le loro difficoltà quando, in ambulatorio o in corsia, si ritrovano ad avere a che fare con un paziente straniero.
Medici e pediatri a cuore aperto i protagonisti della due giorni, dal titolo Segni, sintomo, dialogo. La comunicazione con il paziente straniero, organizzata dall’OMCeO veneziano, il 5 e il 9 febbraio scorso, con la stretta collaborazione dell’assessorato alla Coesione sociale del Comune di Venezia, con cui da anni si è avviato un percorso sul tema.
Un seminario di analisi e approfondimento preparato con grande cura, dopo mesi di lavoro, da un gruppo composto dai camici bianchi – medici di famiglia, pediatri di libera scelta, specialisti ospedalieri, psicoterapeuti arrivati anche da Padova e da Feltre – e dalle operatrici del Comune di Venezia, che nel loro quotidiano si confrontano con le problematiche legate agli immigrati. Questi i loro nomi: Leonardo Albano, Luca Barbacane, Alessandra Cecchetto, Sandra Cozzani, Cinzia Dario, Michela Boscolo Fiore, Gabriele Gasparini, Maria Assunta (Patrizia) Longo, Rebecca Lovisatti, Cristina Mazzarolo, Raffaella Michieli, Maria Pellosio, Andrea Schiavon, Elisabetta Stinà.
«Straniero – ha sottolineato Giovanni Leoni, presidente dell’OMCeO veneziano e vicepresidente della FNOMCeO – non è un insulto, è solo una tipologia di pazienti che non è di questo territorio. Come medici mostriamo oggi di avere un’attenzione a chi arriva da lontano e ha problemi ad esprimersi. Un evento simile non l’ho visto ancora da nessuna parte, nonostante la mia dimensione nazionale. Un’opera prima così estesa e articolata che risponde bene anche alla dimensione politica attuale. Un filone importante su cui continueremo a lavorare».
Presenti per un saluto alla serata inaugurale anche Michele Tessarin, della direzione medica dell’Ulss 3 Serenissima, Maria Caterina De Marco, direttore della funzione ospedaliera dell’Ulss 4 Veneto Orientale, Gabriele Angiolelli, direttore di Distretto dell’Ulss 3 Serenissima, Gianfranco Bonesso, responsabile del Servizio Immigrazione del Comune di Venezia e il magistrato Massimo Michelozzi.
Un lungo confronto per spiegare che le criticità ci sono e sono tante, che vanno affrontate, forse, con una nuova apertura mentale e culturale, ma anche per offrire qualche strumento in più, concreto, di approccio a questi pazienti. Per poter dire, insomma, formulata rimbalzata più volte tra le pareti della sala Caterina Boscolo: si può fare!
Clicca qui per vedere la gallery del 5 febbraio
Clicca qui per vedere la gallery del 9 febbraio
I risultati del questionario
Il seminario è stato anticipato nelle settimane precedenti dalla richiesta ai colleghi di compilare un questionario conoscitivo on line, a cui hanno risposto 200 professionisti. «Un risultato importante per noi – ha spiegato il radiologo e consigliere dell’Ordine Gabriele Gasparini illustrandone i risultati – in cui si sfata anche qualche mito».
A rispondere sono stati in particolare medici di medicina generale, il 34,1%, e pediatri di libera scelta, il 10,4%, «colleghi – ha sottolineato Gasparini – che per lo più lavorano da soli, più del 55% in un ambulatorio singolo». Professionisti che conoscono poco le lingue, fatta eccezione per l’inglese, che hanno un’età elevata, uno su due ha più di 60 anni, e che lavorano nel centro delle grandi città.
«La maggior parte di loro – ha spiegato – ha delle difficoltà con i pazienti stranieri, ma ben il 30% dei colleghi ha risposto di non averne. Solo il 4,2%, poi, dice che tornano troppe volte negli ambulatori per lo stesso problema, rispetto a quante basterebbe. Per due su tre vengono un numero congruo di volte». Poco più di 3 medici su 4, inoltre, dicono di dedicare un po’ più di tempo per visita ai pazienti stranieri.
Secondo i dati, queste le ragioni che spingono gli stranieri a tornare più spesso dal medico: la difficoltà di comprendere prescrizioni e terapie, la scarsa conoscenza dei meccanismi del servizio sanitario, la diversa cultura sanitaria, una comunicazione non efficace o aspettative disattese, il controllo degli esami, per il bisogno di essere rassicurati, perché sanno di essere visitati in tempi rapidi, hanno pochi impegni lavorativi e non costa loro nulla. «Provenendo da realtà – ha aggiunto – in cui l’assistenza sanitaria è di difficile fruizione, il paziente straniero manifesta nei primi mesi una sorta di ingordigia nei confronti di un sistema universale che dà finalmente risposte alle sue problematiche».
I risultati, dunque, sfatano qualcuno di quei luoghi comuni «che dicono che gli stranieri vengono troppo spesso, per motivi futili, che fanno troppa confusione, fanno perdere un sacco di tempo… Beh questa cosa proprio non succede, questa sensazione non c’è. Forse siamo noi più sensibili a vederla così, come quando pensiamo che gli immigrati siano di più di quanti siano in realtà». Sul fronte delle prescrizioni, gli stranieri capiscono quasi tutto, «tranne – spiega il radiologo – la prevenzione e i consigli sugli stili di vita sani, ma qui entra in gioco la loro cultura».
Quasi la metà dei medici che ha risposto al questionario, infine, vorrebbe essere aiutata a migliorare la relazione con il paziente straniero, a uno su 10 non interessa. Se tre medici su 4 non sanno che esistono in città corsi di italiano per i pazienti stranieri, tutti pensano che il loro lavoro sarebbe più facile se l’immigrato sapesse l’italiano. Ed è, allora, proprio la lingua l’ostacolo più complesso da aggirare per chi lavora in sanità. «La soluzione? All’italiana: ci si arrangia… Molti – ha concluso Gasparini – utilizzano il tramite di un familiare che sappia l’italiano, uno su 5 traduce con dr. Google, qualcuno usa i video, l’1% può contare su un mediatore culturale».
Al cuore del problema
Tre i momenti che hanno coinvolto di più i partecipanti al seminario. Il primo, alla fine della serata del 5 febbraio, ha visto protagoniste le operatrici del Comune di Venezia Michela Boscolo Fiore ed Elisabetta Stinà che hanno illustrato i dati della presenza straniera sul territorio veneziano, più alta, al 12,6%, rispetto alla media italiana, persone provenienti soprattutto dal Bangladesh, dalla Romania e dalla Cina e giovani, con un’età compresa tra i 20 e i 59 anni, una presenza quindi produttiva, legata al lavoro, e hanno spiegato come la maggior parte degli stranieri presenti sul nostro territorio non sia arrivata con i barconi ma in altro modo e per altri motivi e non abbia fatto richiesta d’asilo.
Ma, al di là di numeri e cifre, a colpire è stato il video, realizzato dal videomaker Enrico Arrighi, in cui proprio gli stranieri raccontano come vedono i medici e le visite italiane e come si sentono quando entrano in un ambulatorio. Sguardi e volti che chiedono più attenzione all’ascolto, più pazienza, più compassione, che lamentano il minor tempo loro dedicato dal medico rispetto a un paziente italiano, la lunghezza dei tempi d’attesa, le barriere linguistiche che rendono difficile la comprensione, ma che sottolineano anche la gratuità delle visite, aspetto fondamentale rispetto ai paesi di provenienza. Tempo e pazienza le richieste più diffuse. Testimonianze che si trasformano in una presa di coscienza, di consapevolezza collettiva.
Gli altri due momenti molto partecipati hanno visto protagoniste Maria Assunta (Patrizia) Longo, medico di famiglia padovana e formatrice d’esperienza, e Rebecca Lovisatti, psicologa e psicoterapeuta arrivata da Feltre, che nella mattinata del 9 febbraio hanno organizzato il microfono aperto “svuotiamo il sacco” e il “role playing”.
Due spazi in cui i medici presenti si sono messi in gioco in prima persona, guardando in faccia la realtà e raccontando i problemi da affrontare quando in ambulatorio si presenta un paziente straniero. Tante e di tipo diverso le esperienze che si sono volute condividere: un oculista ha sottolineato come sia difficile spiegare la propria specialità spesso anche agli italiani, figurarsi a chi capisce a fatica la nostra lingua. Un radiologo ha parlato, invece, della necessità della presenza di un accompagnatore, «perché – ha detto – è solo con lui che riesci a rapportarti. Se non ci fosse, spesso non si riuscirebbe a fare l’esame: provate a spiegare a una donna del Bangladesh che deve spogliarsi». Un medico che si occupa di invalidità civile, un medico di famiglia e un ortodontista che cura i bambini hanno raccontato, invece, l’imbarazzo di dover parlare di aspetti di salute molto delicati attraverso minori che accompagnano i genitori, ragazzini che si trasformano in traduttori. Adesione alla terapia e necessità di acquisire il consenso informato gli ostacoli da superare. Un altro medico di famiglia, una dottoressa, ha centrato,infine, l’attenzione sull’impatto emotivo pesante che certe situazioni, difficili da gestire, hanno sulla vita del medico. «Con due ragazzi del Bangladesh – ha detto – ho perso la pazienza e mi dispiace, poi ho pensato che dovevo reagire in maniera diversa. Ma c’è una grande fatica...».
Far capire la materia a chi parla poco l’italiano, la patologia, la terapia, le prescrizioni, capire ciò che viene raccontato dai pazienti, la conseguente presenza di minori con ruoli di traduttore, la scarsa conoscenza delle abitudini di vita di chi proviene da altri paesi, della cultura, del tipo di alimentazione, le ripercussioni medico legali e di responsabilità professionale, ma soprattutto la mancanza di tempo i problemi emersi dal confronto.
Una coppia bengalese alle prese con la volontà di fare un figlio nell’ambulatorio di un medico di famiglia la storia che è stata messa in scena durante il gioco di ruolo. Pazienti e medico che non si conoscono, a parlare sempre e solo l’uomo che poi, a volte sì, a volte no traduce alla moglie. Il medico che mai si rivolge a lei, neanche con lo sguardo. Domande a raffica da parte del dottore sullo stato di salute di entrambi e dei loro parenti stretti, domande che ottengono risposte a monosillabi. Parziale inversione di rotta del medico che si accorge di non averci capito niente e riparte facendo una domanda alla volta e conclude la seduta prescrivendo alla donna qualche esame.
Una situazione reale in cui molti si sono immedesimati e su cui i partecipanti sono stati invitati a riflettere, scrivendo i punti di forza e di debolezza dell’azione del collega, da sviscerare poi nella discussione. Tra le criticità individuate: il senso di impotenza in una sorta di dialogo tra sordi tra pazienti e medico; le risposte evasive e monosillabiche che fanno pensare come le domande non siano state comprese, provocando, dunque, insicurezza nel dottore che non sa perché viene detto un sì o un no; qualche termine troppo difficile usato; la figura femminile quasi del tutto assente, “dimenticata” dal medico che non si rivolge mai a lei; tempo azzerato all’inizio nella conoscenza dei nuovi pazienti e troppa fretta nel passare all’elenco delle patologie.
Tra i punti di forza, invece: la tranquillità e l’accoglienza trasmesse dal collega; la disponibilità, il rispetto e la voglia di collaborare sia da parte dei pazienti, sia da parte del medico; il suo riconoscere l’errore nel fare domande a raffica, tornando indietro e ripetendo la prassi con più calma, una domanda alla volta.
«È insostenibile – hanno spiegato alla fine Patrizia Longo e Rebecca Lovisatti – pensare che il medico, tra i miliardi di cose che deve fare, approfondisca anche la cultura di 50 etnie… Il pezzettino, però, che possiamo fare tutti, con i nostri tempi, è un po’ di esplorazione per capire in che mondo rientrano i pazienti che abbiamo di fronte».
Conoscere l’epidemiologia, il primo strumento utile
Fornire strumenti utili e concreti ai partecipanti è stato uno degli obiettivi del seminario. Concretamente si è realizzato negli spazi riservati nelle due giornate all’epidemiologia e alla clinica delle patologie dei gruppi nazionali più rappresentanti nel territorio veneziano.
La prima a parlarne, martedì 5 febbraio, è stata Mara Rosada, direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre (Ulss 3 Serenissima), che ha illustrato i dati di accesso degli stranieri al proprio reparto: nei più di 94mila accessi del 2018, l’81% era costituito dagli italiani, il 4,4% da turisti stranieri e il 14,2% da stranieri residenti. In prevalenza arrivano al Pronto Soccorso i moldavi e i bengalesi, ma hanno un’alta percentuale anche i rumeni e gli albanesi.
«Tra i motivi più diffusi negli accessi degli immigrati – ha spiegato – ci sono problemi ostetrico-ginecologici, cioè gravidanze a termine, o legati a patologie specifiche, problemi oculistici, odontoiatrici, dermatologici». Facilitazioni per il Pronto Soccorso sul fronte delle barriere linguistiche perché può avvalersi del numero verde dell’interpretariato telefonico che offre un servizio di traduzione ad hoc.
La parola è poi passata a Carlo De Riva, direttore dell’Unità Malattie Endocrine sempre dell’Angelo di Mestre (Ulss 3 Serenissima), che ha concentrato il suo intervento su due patologie particolari legate alla cronicità: il diabete, che colpisce in larga parte gli stranieri provenienti dal Bangladesh, e le malattie della tiroide, di cui soffrono di più i cinesi.
Ha spiegato in particolare come i primi siano affetti da patologie metaboliche che insorgono in età più bassa rispetto agli italiani, mettendo a rischio il loro futuro cardiovascolare, a causa dello scarso peso alla nascita dei bambini, legato alla dieta alimentare fatta prevalentemente di riso, e della diversa cultura legata alla prevenzione, per cui in certe aeree del mondo l’uso di alcuni farmaci non è ancora pratica comune.
Un ottimo aiuto in questa direzione è dato da internet. «Sul sito della Società Italiana di Diabetologia – ha spiegato il dottor De Riva – sono stati pubblicati una carta con gli adattamenti dietetici al loro tipo di cultura e religione e gli standard per la cura del diabete mellito con dei passaggi dedicati alla dieta e, ad esempio, al ramadan, digiuno che loro sempre osservano». Dato che non si tratta di gestire urgenze o emergenze, per trattare al meglio questi pazienti, si cerca di farli accompagnare da un mediatore e si consiglia una dieta personalizzata che tenga conto di ciò che piace a queste popolazioni e che limiti riso e spezie.
La popolazione cinese, invece, nonostante sia stato il primo Paese al mondo a introdurre il sale iodato per legge, è quella più esposta alle malattie della tiroide: ne soffrono 200 milioni di persone e il 19% delle donne in età fertile. «Nella cultura cinese – ha detto l’endocrinologo – lo iodio fa parte di un karma: mangiane tanto perché così avrai tanti figli. Un uso eccessivo di iodio, dunque, cultura che ora è approdata anche in Italia».
Nella mattinata del 9 febbraio, invece, si sono toccati altri aspetti. I due relatori, Nicoletta Frigato, cardiologa dell’Ospedale di Mirano (Ulss 3 Serenissima), e Pier Giuseppe Flora, direttore della Pediatria e della Patologia Neonatale di San Donà di Piave (Ulss 4 Veneto Orientale), hanno presentato tantissimi casi clinici per illustrare, la prima, le patologie cardiovascolari e i fattori di rischio che corrono gli immigrati e, il secondo, casi riguardanti i bambini, che sono davvero capitati in ospedale.
La dottoressa Frigato, dopo aver illustrato i dati di accesso al suo reparto degli stranieri e il tasso di mortalità, ha parlato della prevalenza dell’infarto negli uomini e di angina pectoris nelle donne; di come ci sia un’alta percentuale di persone, soprattutto uomini, che non è consapevole della malattia, cioè di essere iperteso o di avere il colesterolo troppo alto; di un alto numero di persone che non fa attività fisica nel tempo libero e che fuma troppo; di come l’età di insorgenza della patologie cardiovascolari sia negli stranieri anche di 10-15 anni in meno rispetto agli italiani.
«Per queste persone – ha spiegato – l’accesso ai servizi sanitari è più difficile, anche per la disinformazione, e la prevenzione viene totalmente trascurata». Da lei un consiglio ai colleghi: cercare di conoscere almeno l’incidenza, le diverse caratteristiche e i fattori di rischio legati alle varie etnie.
Tra i casi analizzati dal dottor Flora, invece, quello di un bambino di 5 anni albanese per cui si sospettava un linfoma o una leucemia e, invece, per sua fortuna, era affetto solo da una leishmaniosi, perfettamente curata; quello di un bimbo di colore, anche lui di 5 anni originario del Burkina Faso, mandato dal chirurgo per un addome acuto, a cui si è diagnosticata, invece, una malaria cerebrale; quello di un lattante nigeriano di 8 mesi approdato al Pronto Soccorso per un difetto respiratorio, ma che si è scoperto subito dopo essere stato appena stato circonciso da un santone nigeriano.
Le implicazioni medico-legali
Altri temi di carattere molto pratico: le indicazioni che arrivano dal Codice Deontologico e le implicazioni medico-legali, di cui hanno parlato Alessandra Cecchetto e Cristina Mazzarolo, consigliere dell’Ordine veneziano e componenti della Commissione Pari Opportunità.
La dottoressa Cecchetto, dopo aver raccontato alcune delle sue difficoltà a rapportarsi con le pazienti e i pazienti stranieri durante la sua attività di ginecologa, la sensazione, ad esempio, di dire una cosa e che ne fosse capita un’altra, o di parlare con figli e mariti di sessualità o di interruzioni di gravidanza, è passata a illustrare i punti del codice che suggeriscono indicazioni pratiche. «Ricordiamoci però – ha detto subito – che all’articolo 3 il nostro codice parla di “persona”, non di cittadino o di straniero, a cui dobbiamo prestare le nostre cure senza alcuna discriminazione, e che all’articolo 32 si parla dei nostri doveri nei confronti dei soggetti fragili, dei pazienti in difficoltà». Abbattere le disuguaglianze di salute, favorire l’integrazione degli stranieri, facilitare l’accesso alle cure, umanizzare i servizi sanitari, comunicare in modo efficace, completo ed esaustivo con i pazienti, la segnalazione alle autorità competenti degli abusi o dei maltrattamenti gli altri principi suggeriti dal codice. «C’è anche – ha concluso – un ruolo sociale che il medico svolge per cambiare le cose. Se noi cominciamo a lavorare bene perché l’integrazione sia possibile, diventi più reale, ottemperiamo pienamente a uno dei compiti che ci assegna il Codice Deontologico».
«La comunicazione terapeutica – ha esordito la dottoressa Mazzarolo – di fatto è l’elemento costitutivo di ogni nostro atto sanitario e dà la liceità stessa ai nostri atti sanitari. Un rapporto biunivoco tra almeno due persone, gli attori principali il medico e il paziente, ma che può coinvolgere anche altri individui, con cui noi riusciamo a capire le problematiche e le esigenze e a risolverle. Adesso la norma prevede l’espressione in forma vincolata scritta del consenso informato, che è l’esito finale di questo rapporto comunicativo e terapeutico tra il medico e il paziente».
Una norma – la 219 del 2017, la legge sulle DAT, Disposizioni Anticipate di Trattamento – che dà indicazioni molte precise, requisiti formali che sostanziano la validità stessa della comunicazione e la liceità dell’atto sanitario e che, se non vengono soddisfatti, possono portare il medico a dover rispondere dei propri atti di fronte alle gerarchie delle fonti giuridiche, in ambito penale, civile, amministrativo e deontologico. Violenza privata, lesioni personali dolose e omicidio preterintenzionale i reati sotto il profilo penale di cui il professionista potrebbe trovarsi a rispondere.
«Ognuno di noi – ha proseguito – ha lunghe liste d’attesa e tempi contingentati per le visite. Non è sempre facile fornire una comunicazione terapeutica completa ed esaustiva, che soddisfi le esigenze dei pazienti. Con gli stranieri le cose si complicano di più perché si presentano anche le barriere linguistiche, spesso non irrilevanti, che non possono essere segnalate in alcun modo su moduli e certificati e che, comunque, non salvano il professionista sotto il profilo della responsabilità».
Qualche problema di validità della comunicazione terapeutica può nascere anche se si usa come traduttore un minore. «Una possibilità – ha sottolineato ancora – che le leggi consentono, ma quando una mamma cinese porta come traduttore un bimbo di 7 anni bisogna riflettere sulla capacità che questo bambino ha di capire la problematica sanitaria che devo trasmettere alla madre. Come verrà fatta questa traduzione? E questa comunicazione che valore potrà avere sotto il profilo giuridico?».
Esperienze vive: si può fare!
Importanti nell’arco di questo lungo e articolato seminario anche le due esperienze vive di lavoro con gli immigrati, una locale e una nazionale, presentate durante la mattina del 9 febbraio. La pediatra dell’Ulss 3 Serenissima Cinzia Dario ha raccontato, con l’aiuto di un video, un incontro al Parco Piraghetto di Mestre con un gruppo di donne straniere, proposto dalle operatrici del Comune Michela Boscolo Fiore ed Elisabetta Stinà.
Ma più che l’incontro in sé è stato fondamentale il percorso su se stessa fatto proprio dalla pediatra. «Nello studio in cui lavoro a Marghera con altre due colleghe – ha detto – ci sono bambini che provengono da 50 paesi diversi. A ottobre i cittadini non italiani erano più di 1.100. Senza i bimbi stranieri la lista dei miei iscritti si ridurrebbe in modo significativo. Io, però, non so alcuna lingua straniera». Ostacolo non da poco se si deve affrontare una platea di immigrate.
«Così – ha proseguito – ho deciso che avrei parlato solo italiano, perché prima o poi anche loro devono impararlo, che avrei usato delle immagini e dei gesti concreti per spiegare i dosaggi dei farmaci o come trattare le ferite. Io non ho studiato, non ho fatto corsi, non ho partecipato a convegni, ma ho individuato dei contenuti che volevo far arrivare alle mamme e mi sono lasciata andare alla mia creatività. Oggi sono qui a dirvi che: si può fare! Ognuno a modo proprio». E se comunicare una diagnosi o un percorso terapeutico complesso non è sempre facile, si può cominciare da ciò che spesso si dà per scontato, ma che invece tanto scontato non è.
«L’incontro – ha concluso – è riuscito. Incontrare queste donne mi ha obbligato a mettermi in gioco: mi sono messa al posto delle donne straniere per immaginare i loro bisogni. Ho parlato solo in italiano ma in modo semplice, ripetitivo, senza fretta. Ho portato ausili, come le siringhe, facilmente reperibili. Ho cercato di far partecipare le signore coinvolgendole. Non è cambiato il mio sapere, è cambiato il mio atteggiamento: ho cercato di prendermi cura di queste mamme costruendo il mio intervento su quello che pensavo potesse essere il loro bisogno. È necessario e utile per noi imparare a metterci dalla parte dei nostri pazienti. Tutti, stranieri e no».
Immagini e musica d’impatto a sottolineare la toccante testimonianza di un’altra pediatra veneziana, Maria Pellosio, presidente dell’associazione Rafiki – Pediatri per l’Africa, che ha presentato il Progetto Pozzallo, avviato per accogliere e assistere i migranti, quasi tutti passati attraverso i famigerati campi libici, approdati nel nostro Paese.
«Tra giugno e settembre del 2015 – ha spiegato – abbiamo accolto e assistito circa 5mila migranti, nel 2016 oltre 7.200, nel 2017 fino a fine luglio circa 4mila per poi avere un crollo drastico coinciso con il decreto Minniti, gli accordi con la Libia. A colpirmi sono stati gli sguardi, impauriti e intimoriti, di queste persone che, spesso, comunicavano molto più delle parole. I nostri sguardi, i nostri gesti, invece, dovevano essere rassicuranti».
Tanti i minori non accompagnati: bambini di 12, 13 anni completamente soli. «Ci è capitato – ha proseguito – di prestare a questi ragazzi il nostro cellulare per chiamare casa e rassicurare le famiglie, che non avevano loro notizie da mesi. Ricordo un ragazzo di neanche 17 anni che aveva soggiornato in un campo libico per oltre un anno: un metro e 80 di ragazzo, pesava 47 chili. Aveva mangiato solo pane e acqua. Situazioni che restano per noi indelebili».
Un’attività, quella di questi medici, che «non è eroica – sottolinea la dottoressa – abbiamo il grande privilegio di offrire aiuto a persone meno fortunate di noi, nate in una parte sbagliata del mondo. La relazione è apertura e reciprocità: lavoriamo duramente ma quello che portiamo a casa è superiore a quello che lasciamo di nostro».
E se non tutti i medici e i pediatri possono sentirsi pronti ad affrontare esperienze simili, un aiuto si può dare comunque. «Basta solo, ad esempio – ha concluso la dottoressa Pellosio – rendersi disponibili a sostituire i colleghi che partono. Anche così, si può fare».
Tirare le somme: gli strumenti utili
«Sta bene, ha qualche malattia? No. Ha il diabete? Sì?». «Quando ha tolto il dente? Il primo ottobre. E la febbre quando è salita? Oggi. Oggi siamo il 30 ottobre, sono passati 30 giorni… Ho male per il dente. Ma adesso o il primo ottobre? ». Sono solo un paio dei surreali dialoghi con i pazienti stranieri registrati e mostrati dal medico di medicina generale Raffaella Michieli nel suo ambulatorio in via Cappuccina a Mestre, in apertura della mattinata del 9 febbraio.
Situazioni reali che molto dicono sulle difficoltà che i camici bianchi si trovano ad affrontare ogni giorno nel loro lavoro. «Abbiamo una responsabilità – ha ribadito – nei confronti di tutte le persone che accedono ai nostri ambulatori. Dico di tutte, perché per noi non c’è alcuna differenza. Non solo: il nostro Codice Deontologico, come abbiamo sentito, ci obbliga a insegnare, a far capire agli stranieri come funziona il nostro servizio sanitario. Siamo qui per tirar fuori i nostri mal di pancia: da qui deve uscire una nuova modalità d’approccio».
Una nuova modalità d’approccio, un cambio di mentalità, come hanno spiegato in conclusione Maria Assunta (Patrizia) Longo e Rebecca Lovisatti, che parte da alcuni strumenti pratici:
- spendere al meglio i 10 – 15 minuti dell’incontro tra medico e paziente, perché ogni relazione incomincia con un racconto;
- pretendere il tempo per la comunicazione, «perché – ha sottolineato la dottoressa Longo – la professione ha l’autorevolezza per rivendicarlo»;
- acquisire una consapevolezza di fondo su quello che succede nella relazione e apprendere almeno un po’ di strategia del colloquio nelle sue diverse fasi, per evitare di essere travolti dalla storia del paziente;
- pensare a una comunicazione circolare: «siamo ferrati – ha aggiunto – sulla comunicazione in uscita, la diagnosi, le prescrizioni, ma meno su quella in entrata, ciò che il paziente ti porta. Sondiamo le sue convinzioni, cerchiamo di capire che informazioni ha già. Tutto questo va accolto, ma anche governato»;
- non dare per scontato che siano chiare le prescrizioni o le indicazioni di comportamento che diamo, per i pazienti stranieri possono essere difficili da capire;
- evitare le domande multiple, a raffica: servono a ottenere dati utili in poco tempo, ma creano confusione;
- fare domande aperte orientate la problema: “Cosa ha fatto finora per questa cosa?”
- usare domande narrative per esplorare le prospettive del paziente e il suo illness, cioè il modo in cui il paziente indossa la malattia, come la percepisce;
- ascoltare in modo attivo, facendo domande di contesto e di verifica;
- usare un linguaggio adeguato al paziente, integrabile col suo patrimonio valoriale, essenziale e accuratamente scelto;
- dare indicazioni brevi, proporzionate all’argomento, orientate, concrete, traducibili in comportamenti. Non dire, insomma: “Faccia un po’ di movimento” perché quel “un po’” può essere diverso per ogni individuo;
- essere consapevoli che sul medico vengono proiettate aspettative di tanti tipi.
«Bisogna insomma – ha concluso la dottoressa Lovisatti – uscire dal quadrato della nostra cultura: non dare per scontate le cose. Serve il tempo per formarsi e per riflettere: lavorando su questi aspetti, si lavora meglio sulla complessità della relazione medico-paziente, non solo straniero». Di lavoro da fare, dunque, ce n’è ancora molto e l’OMCeO veneziano non si tira indietro.
Chiara Semenzato, giornalista OMCeO Provincia di Venezia
Segreteria OMCeO Ve
Categoria News:
Notizie medici
Pagina visitata 8218 volte